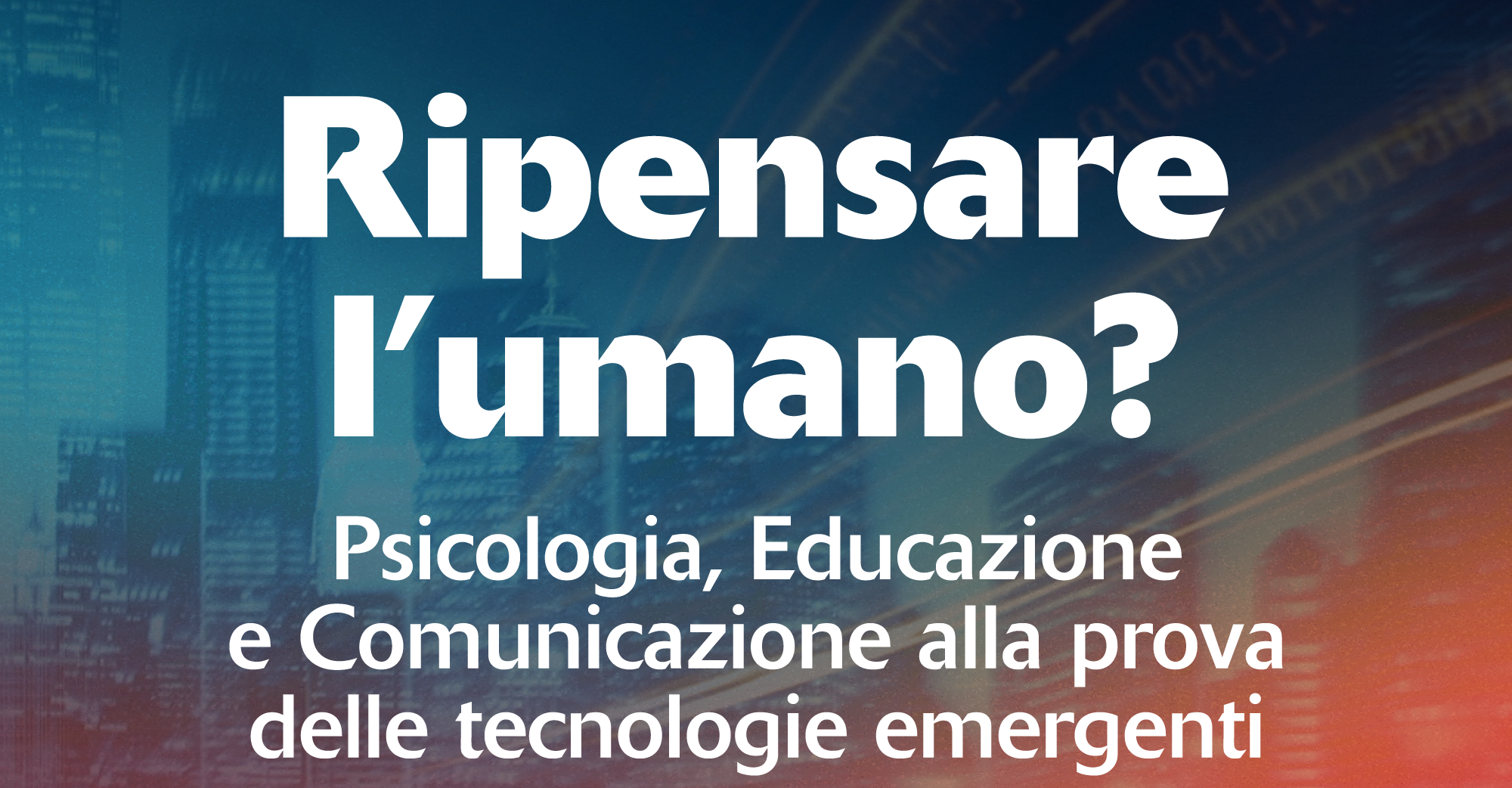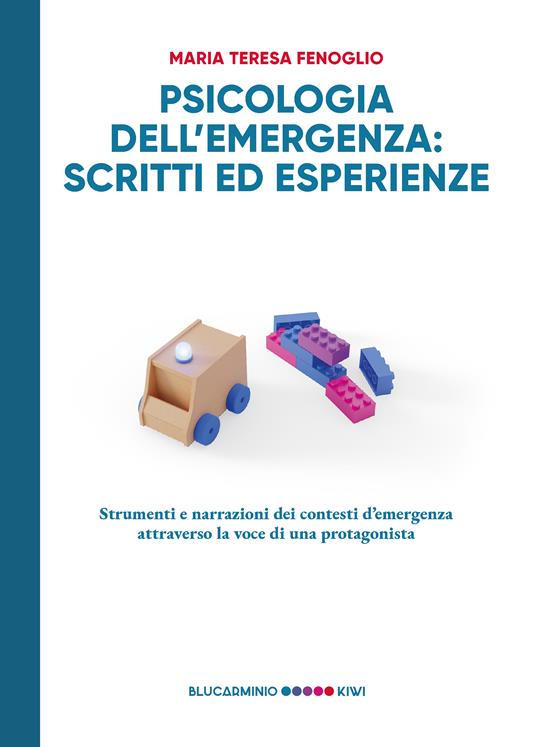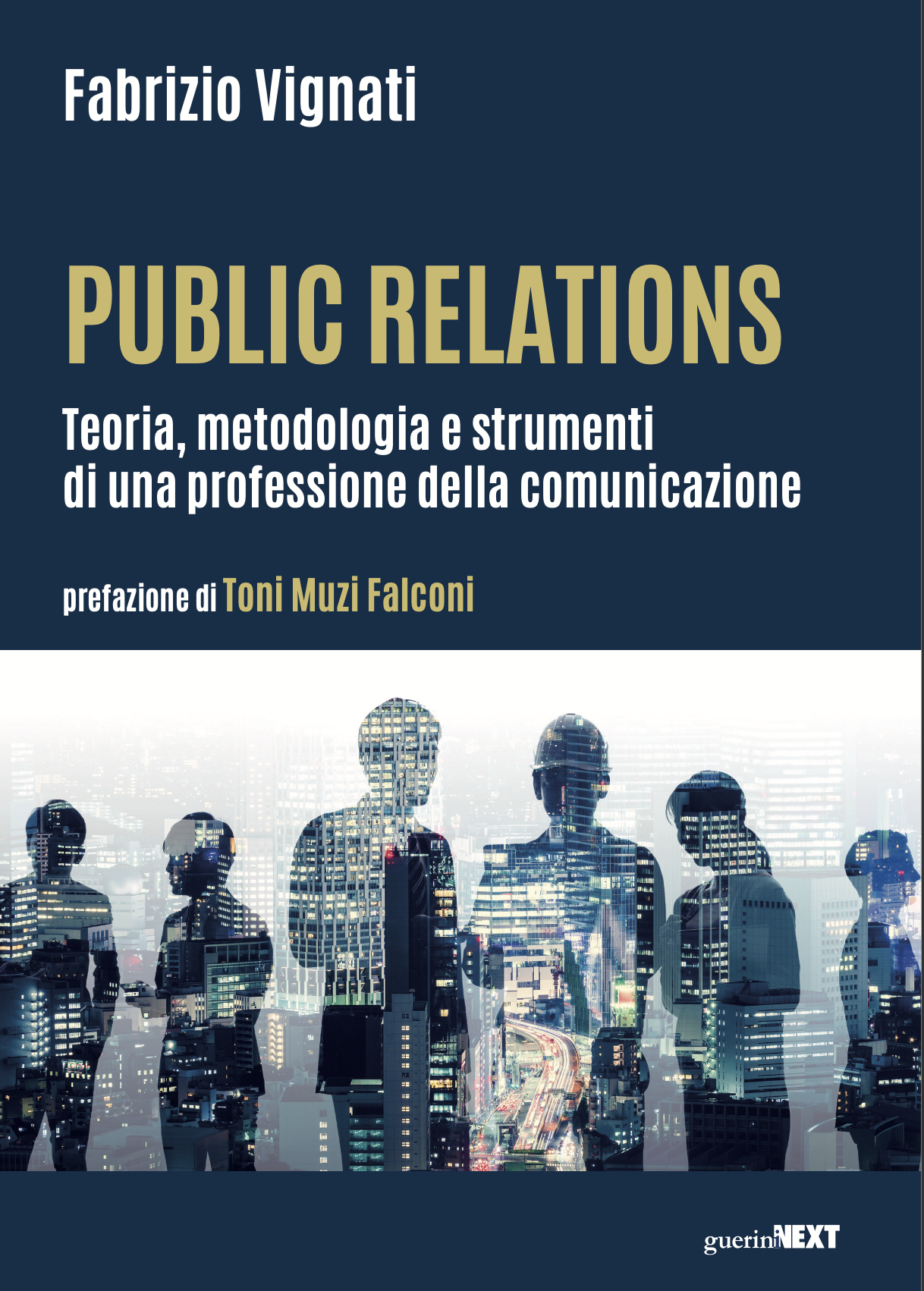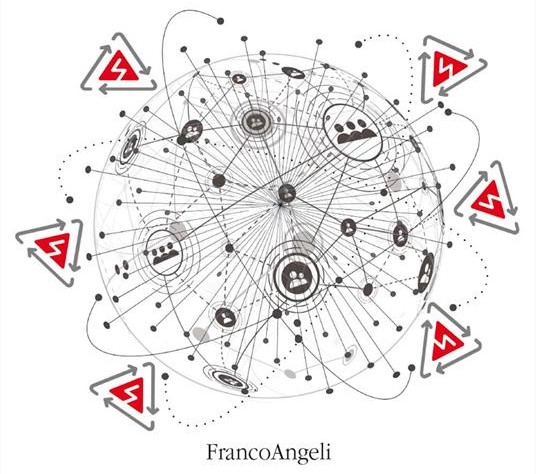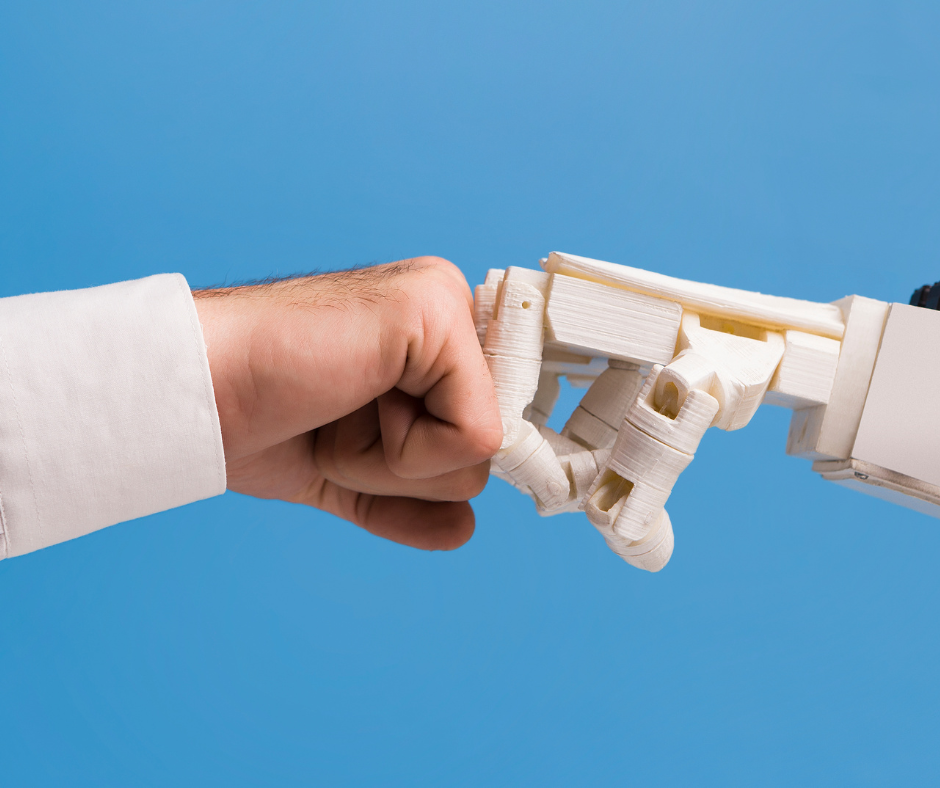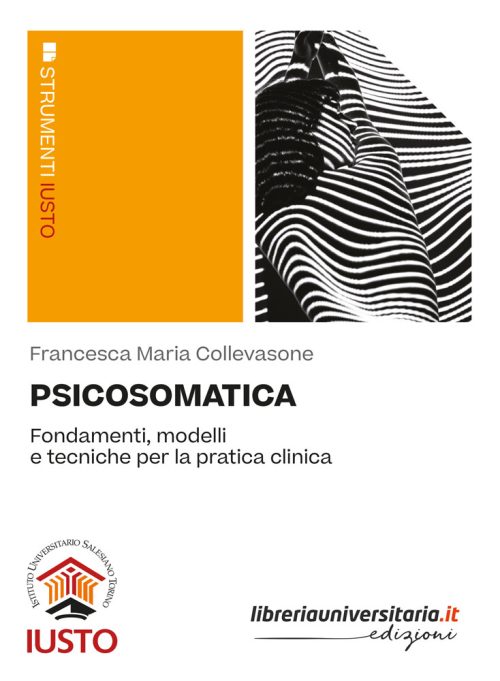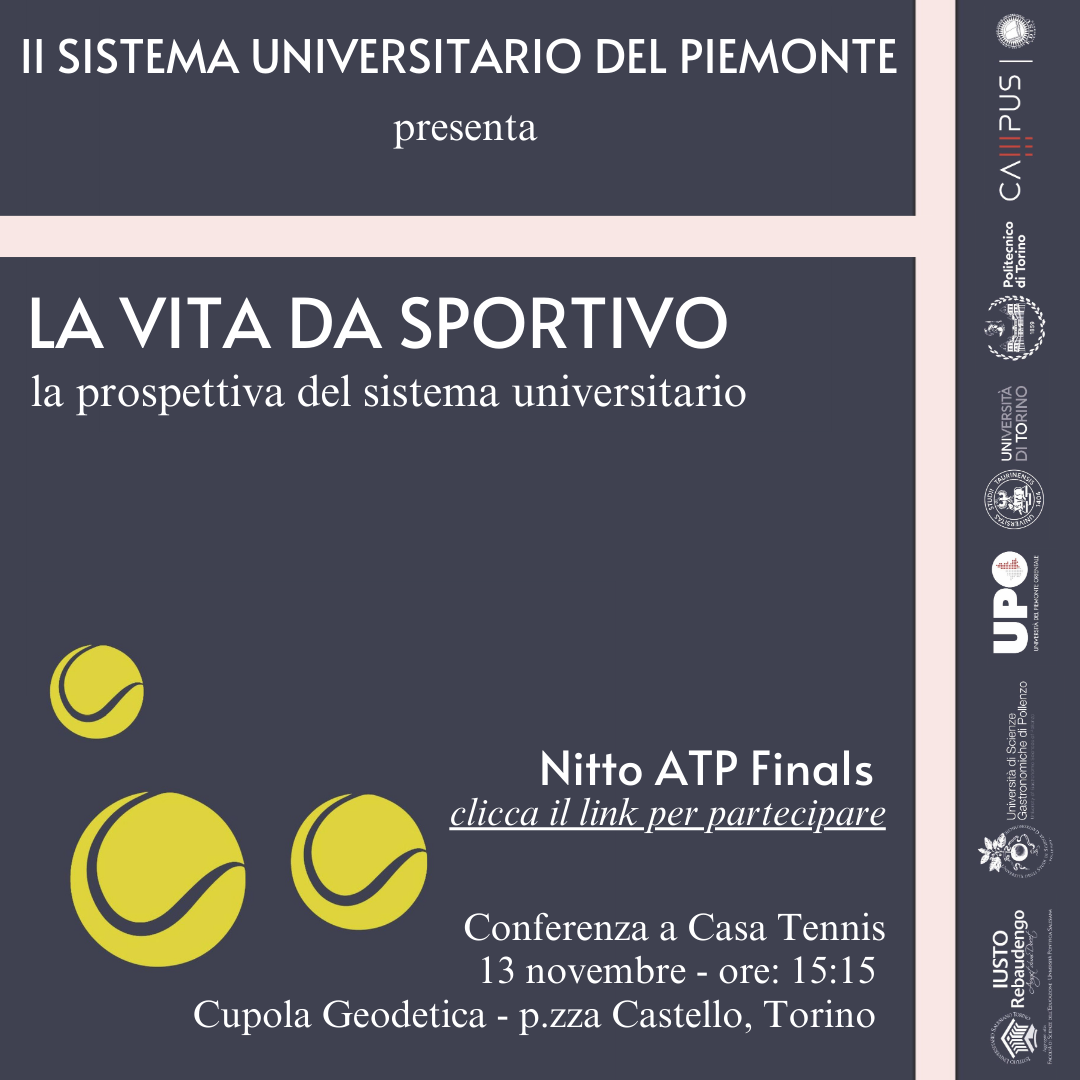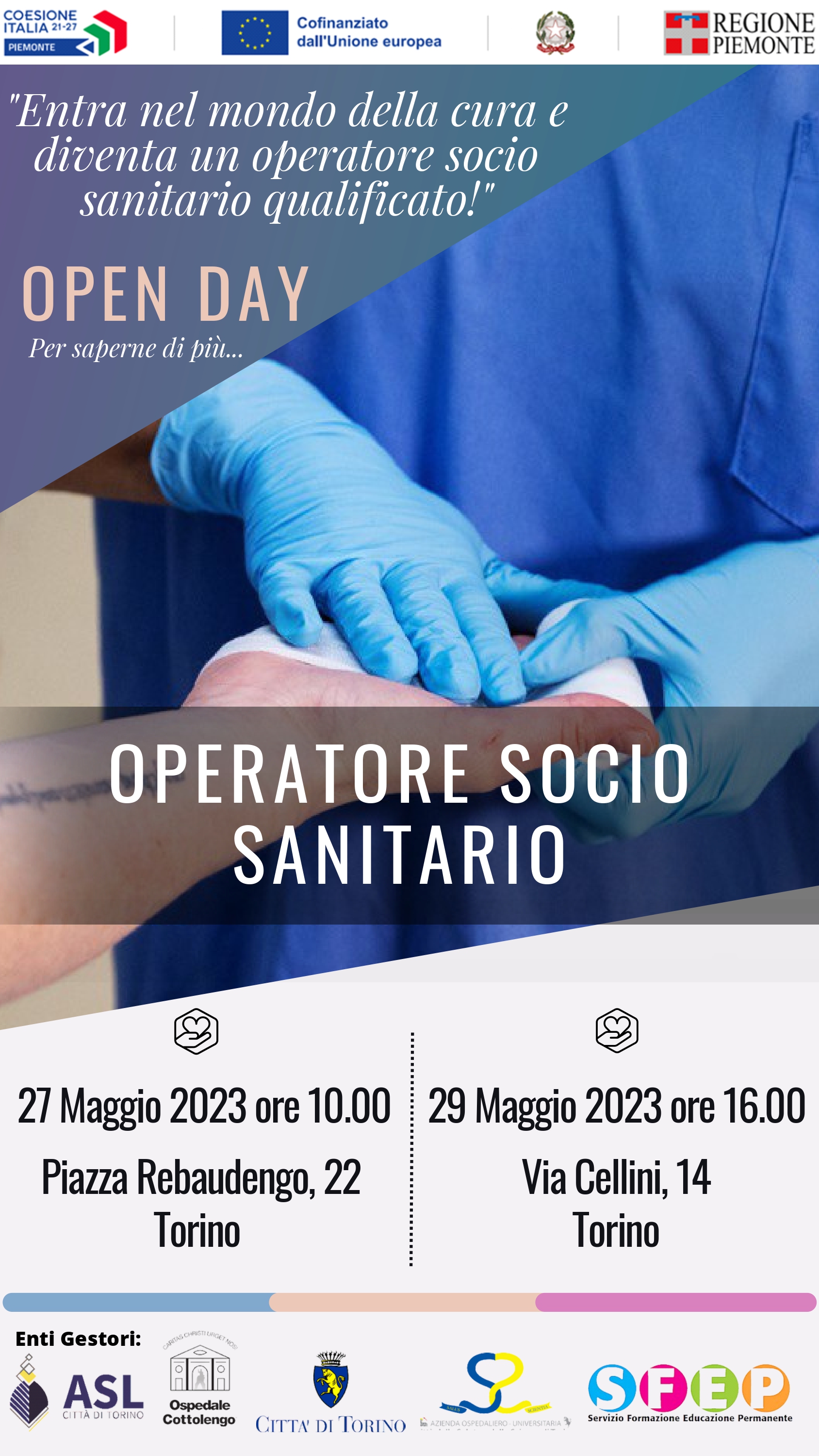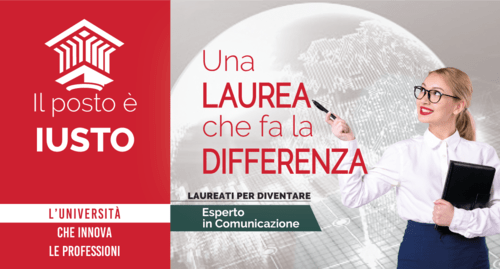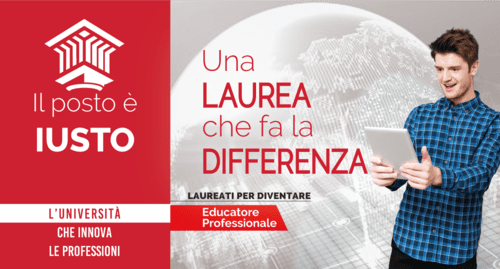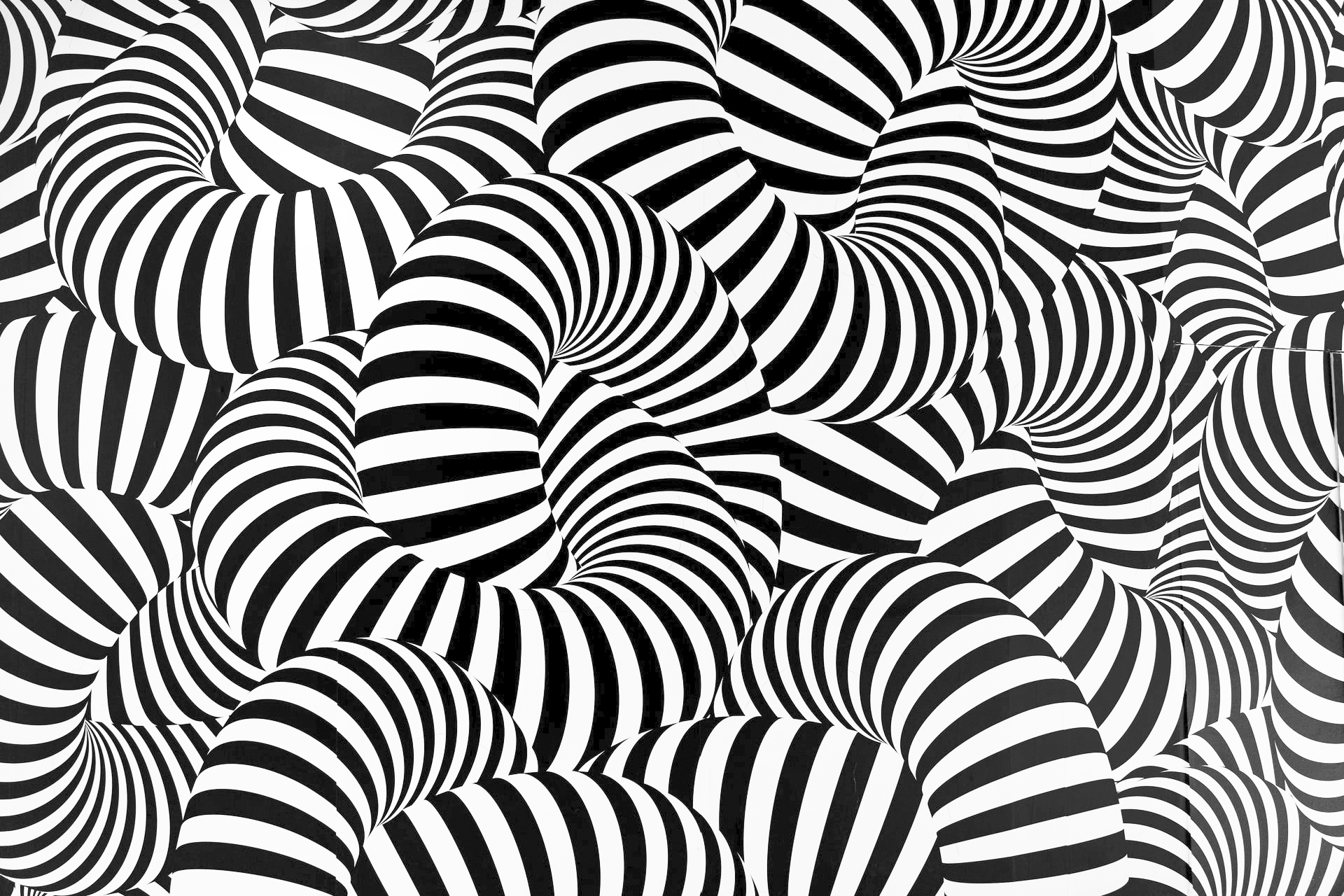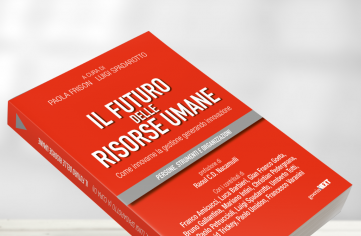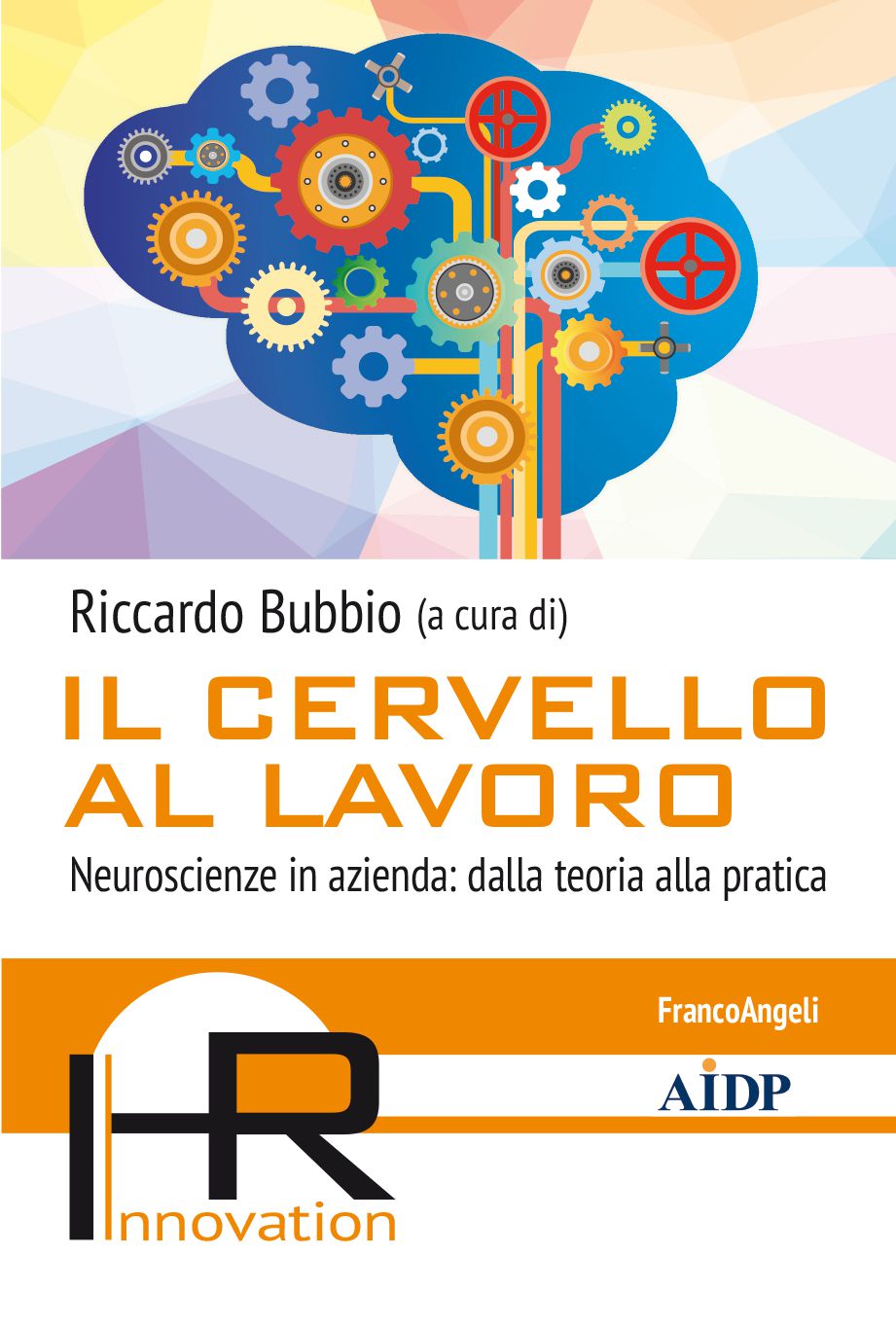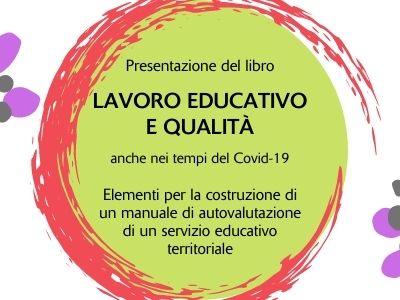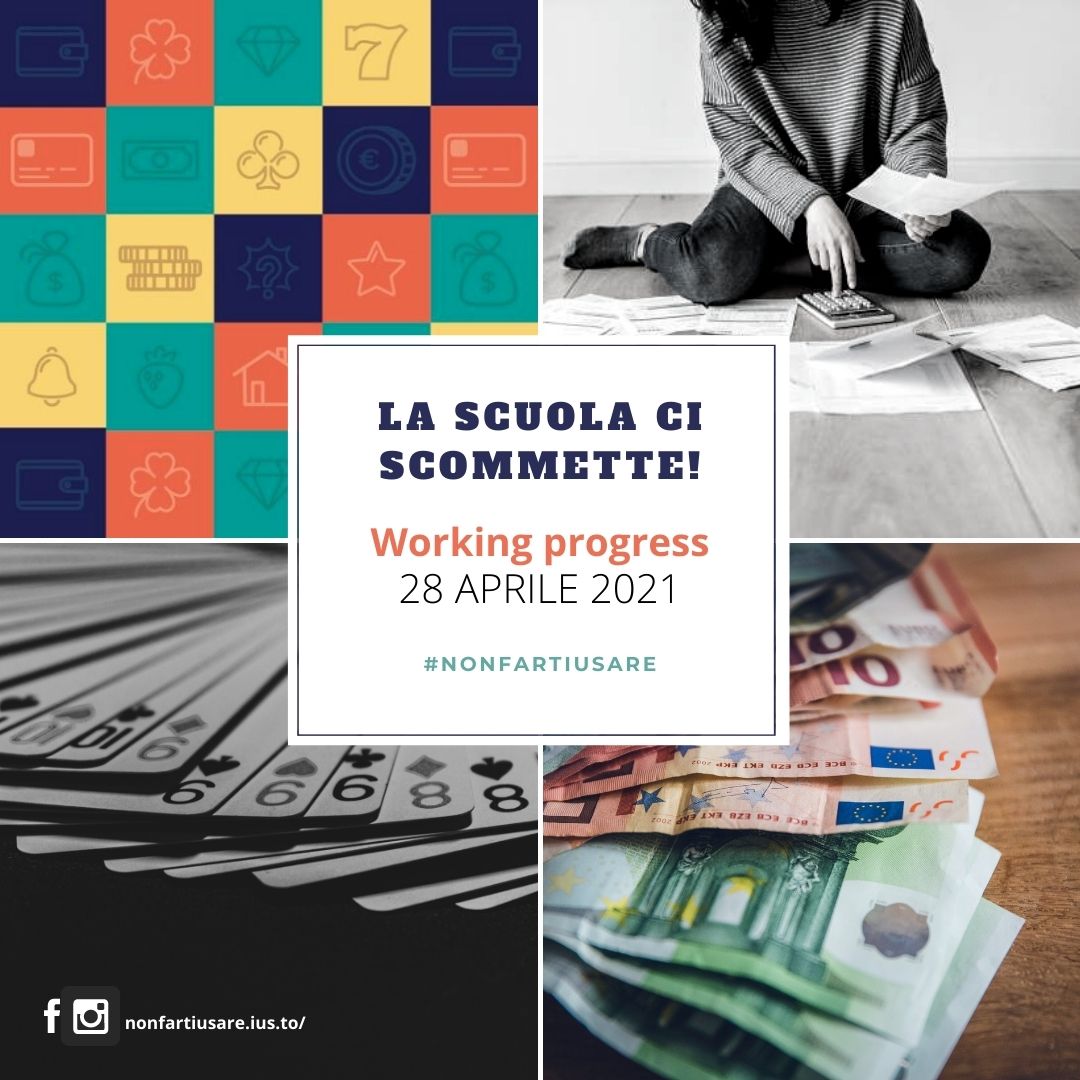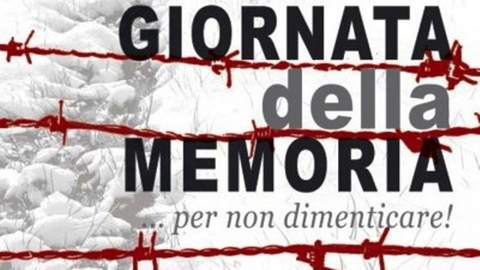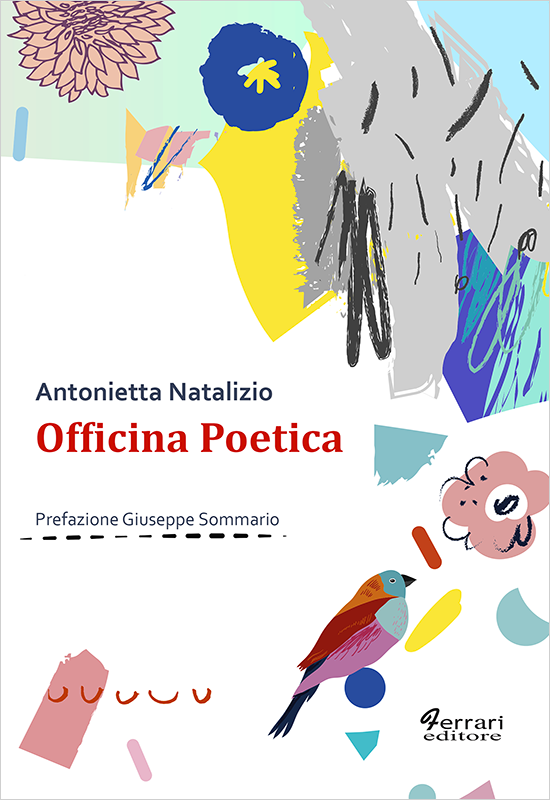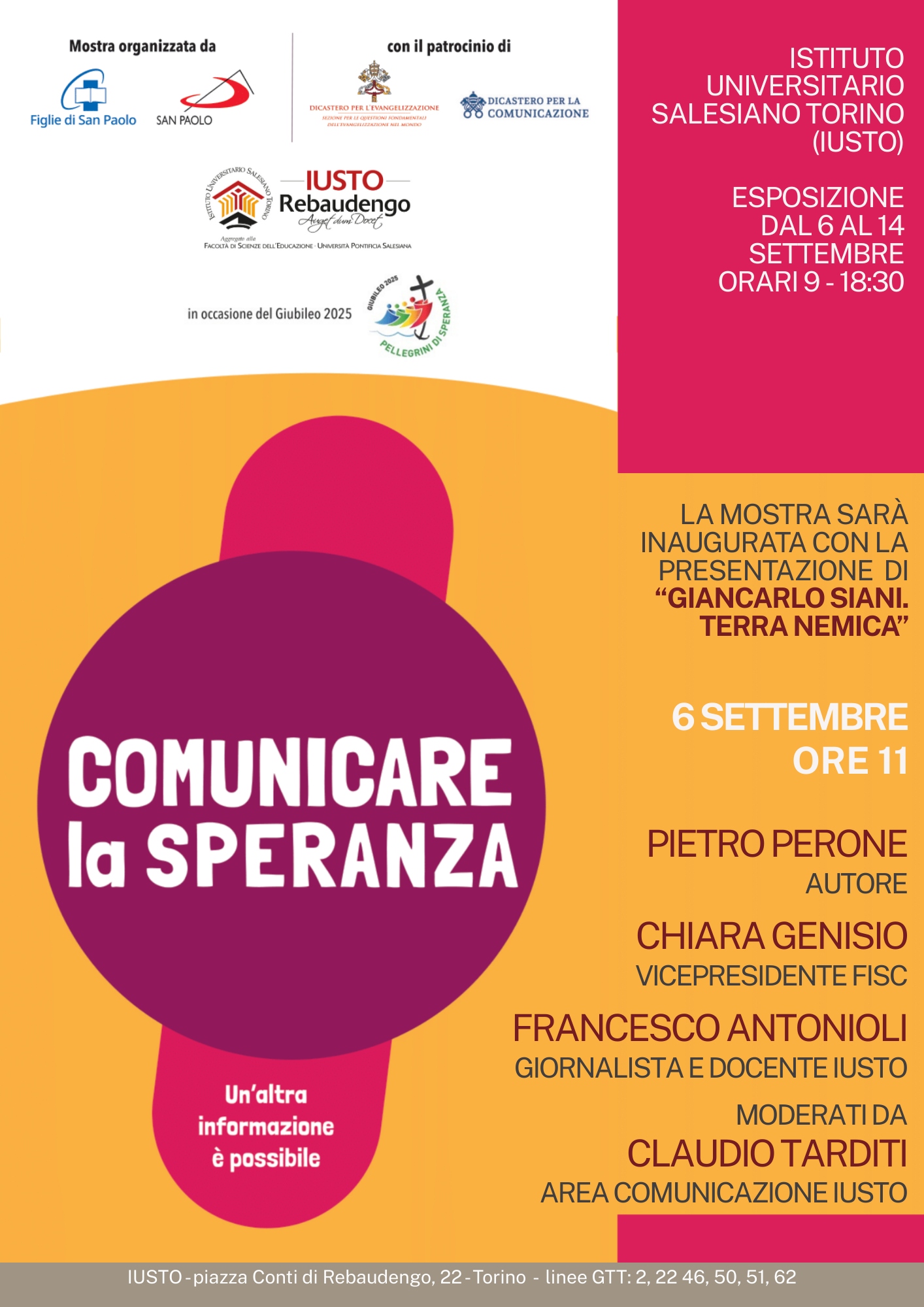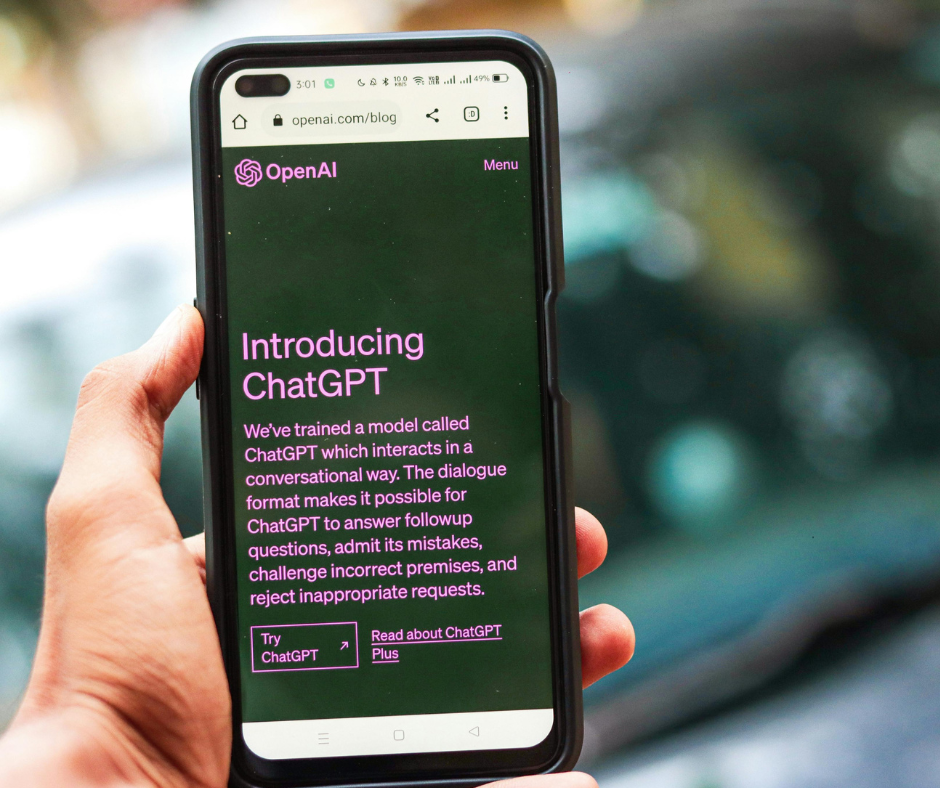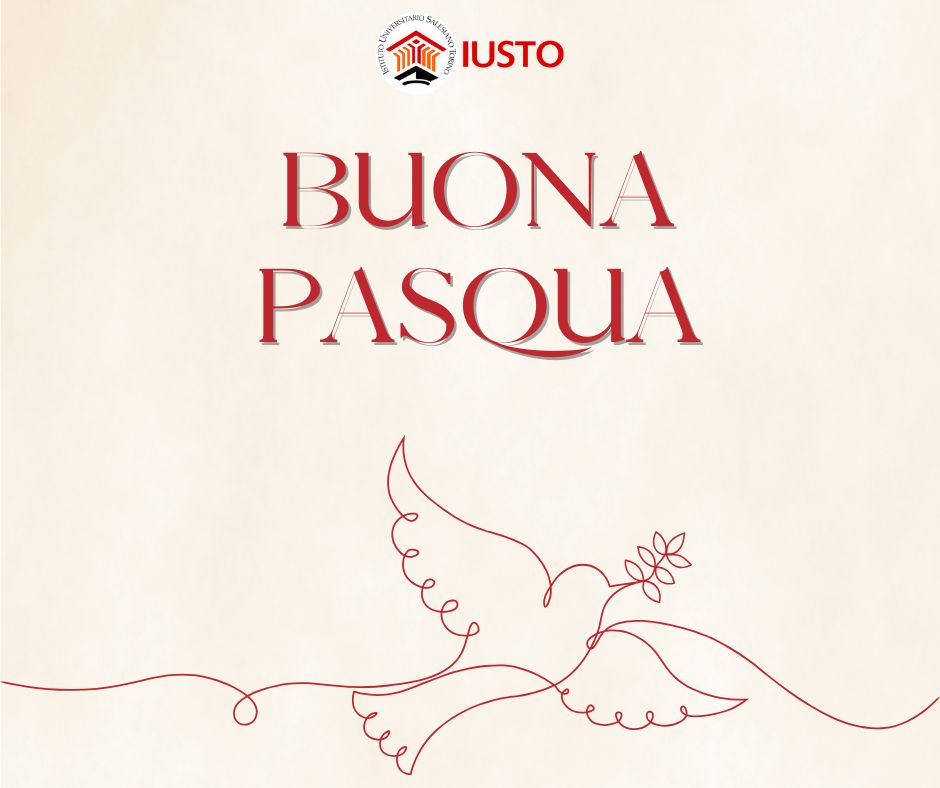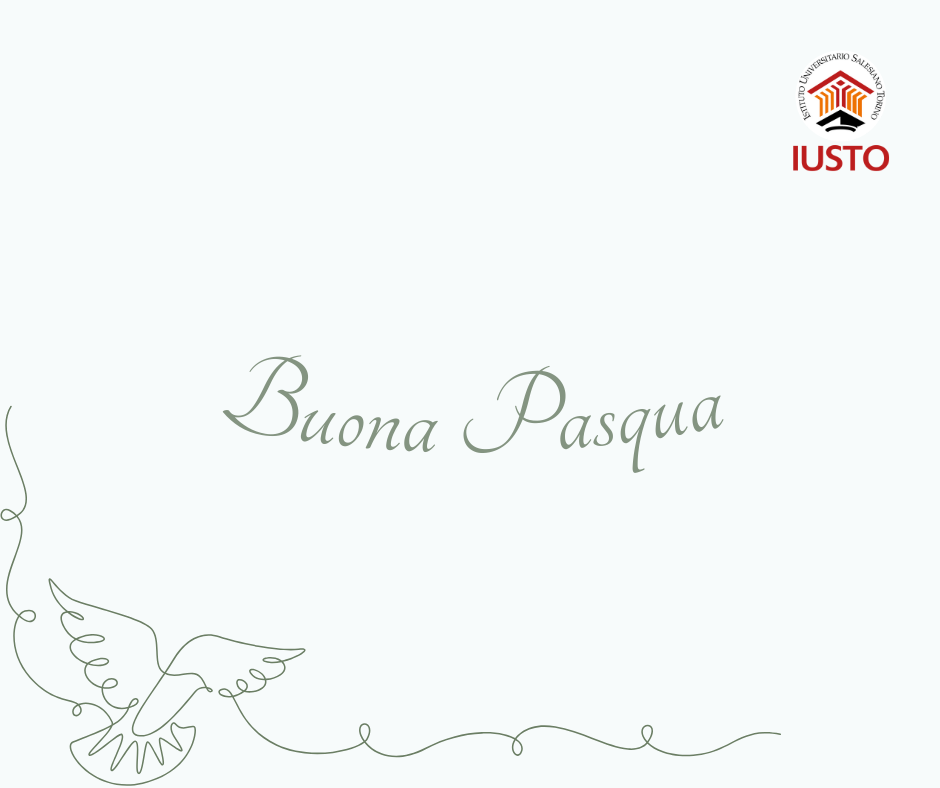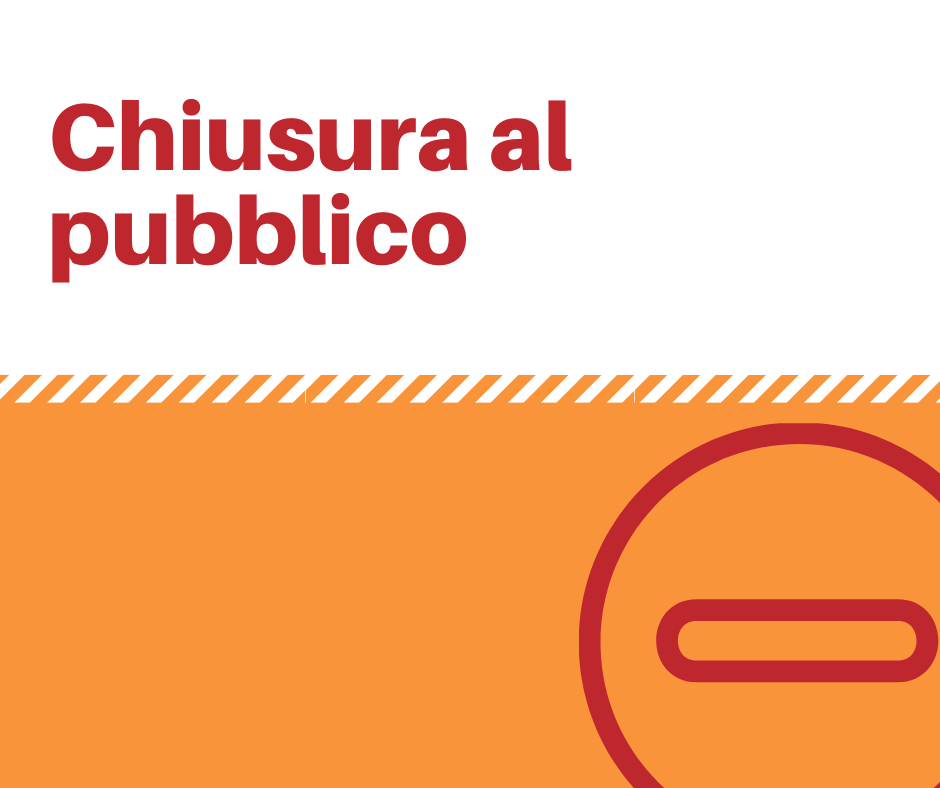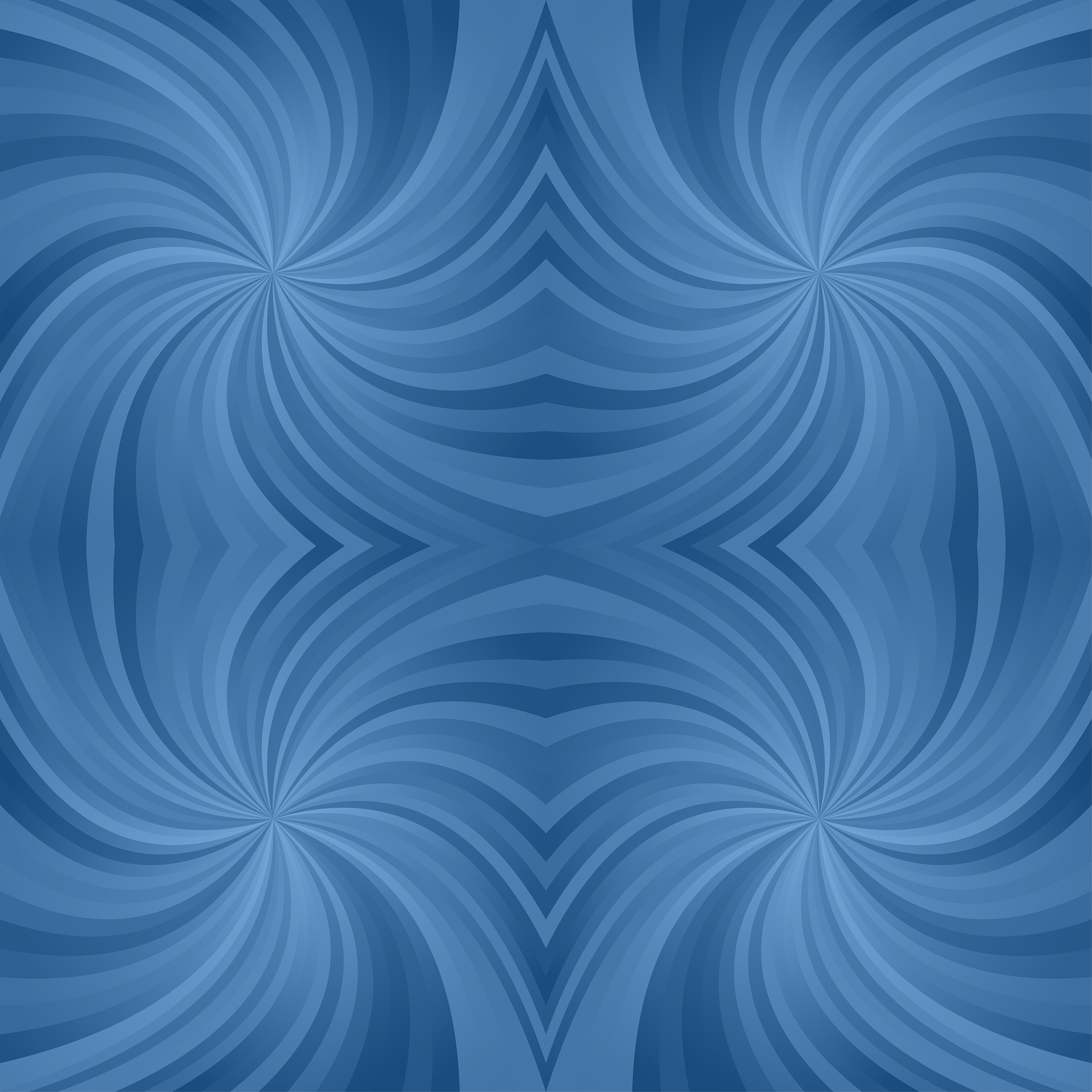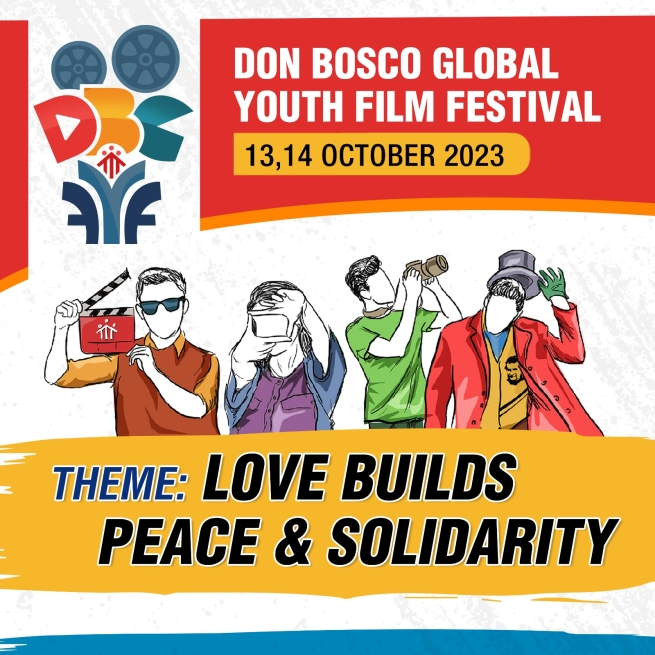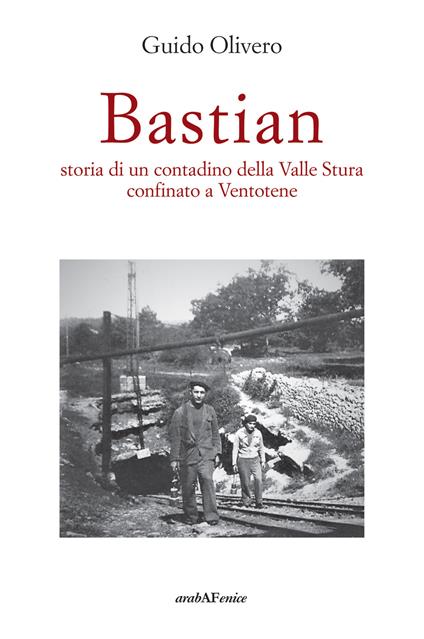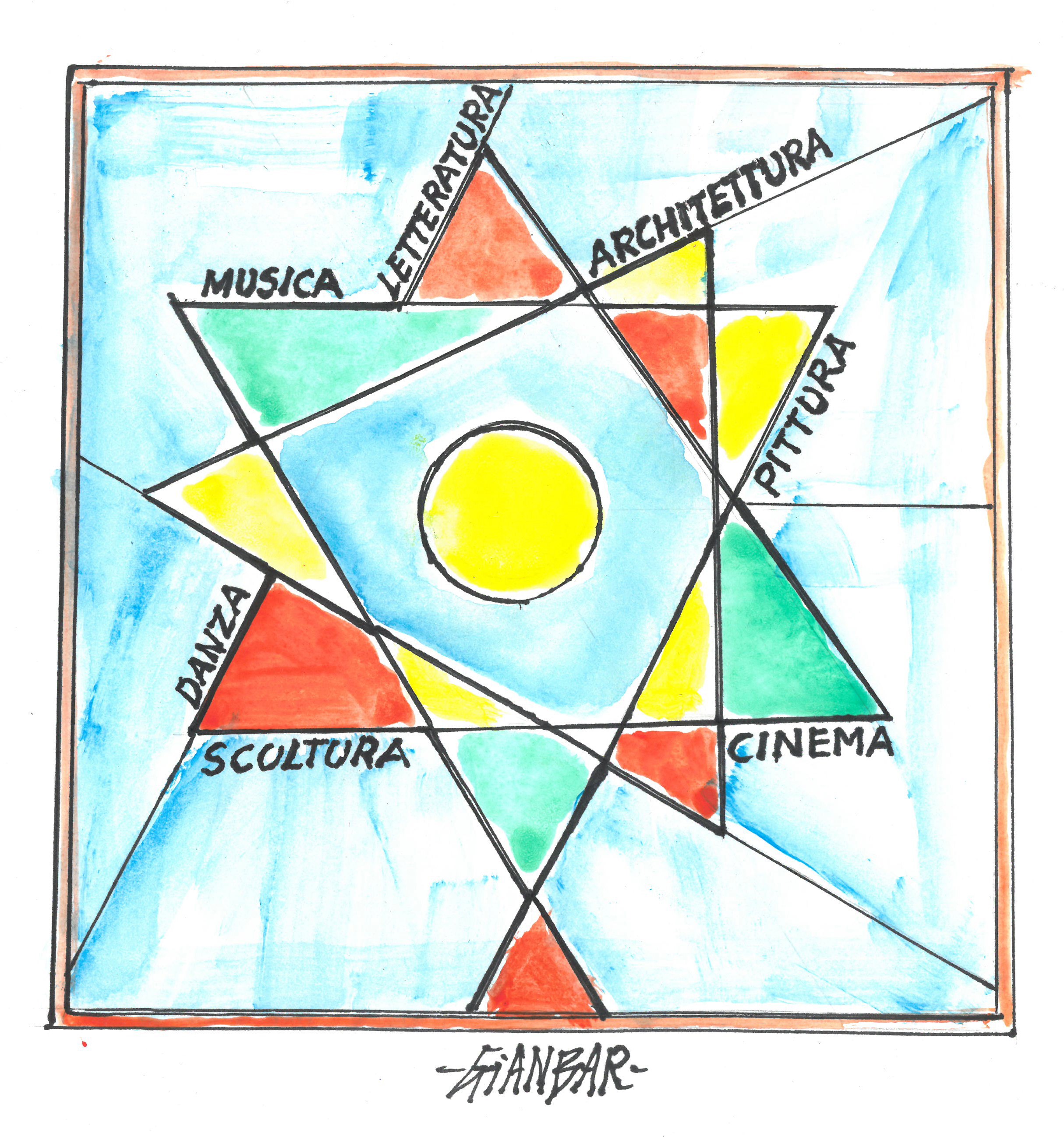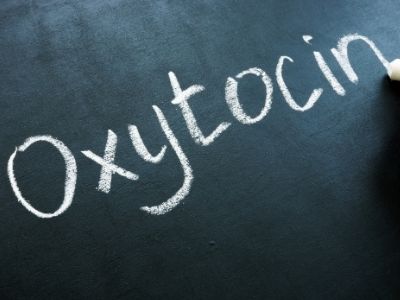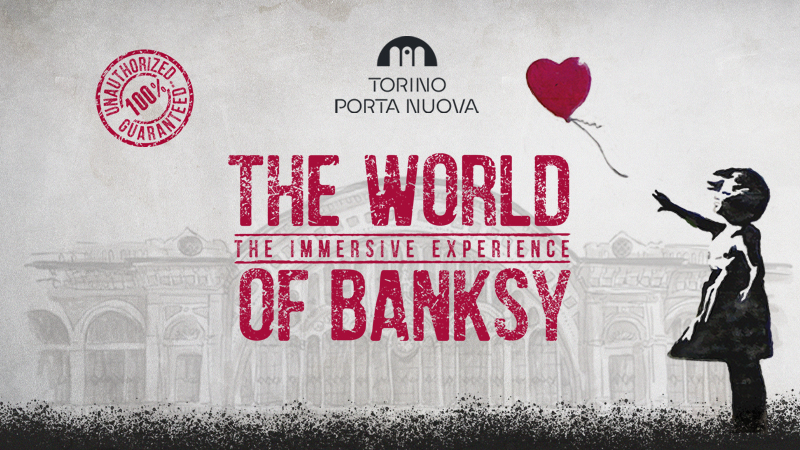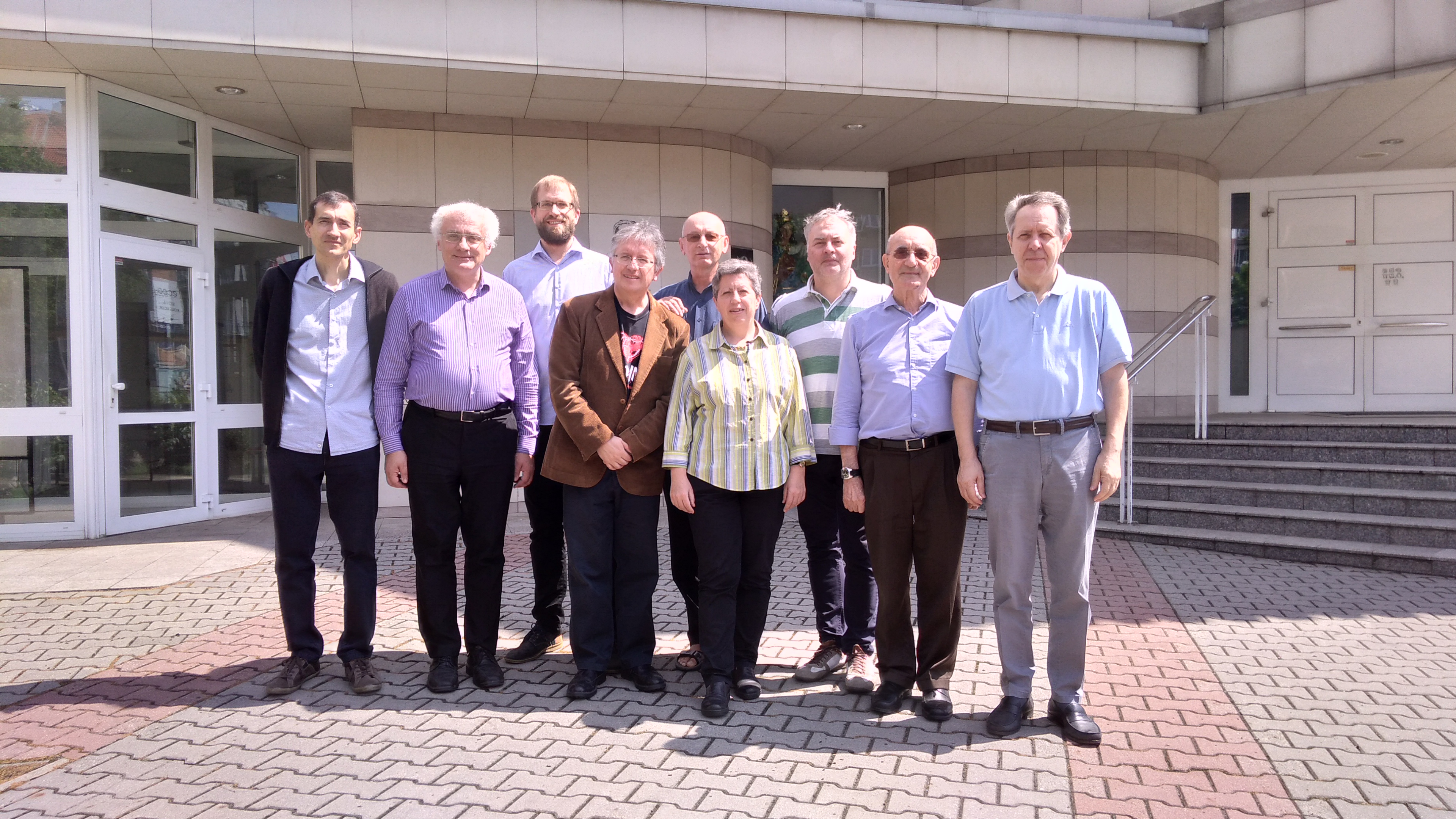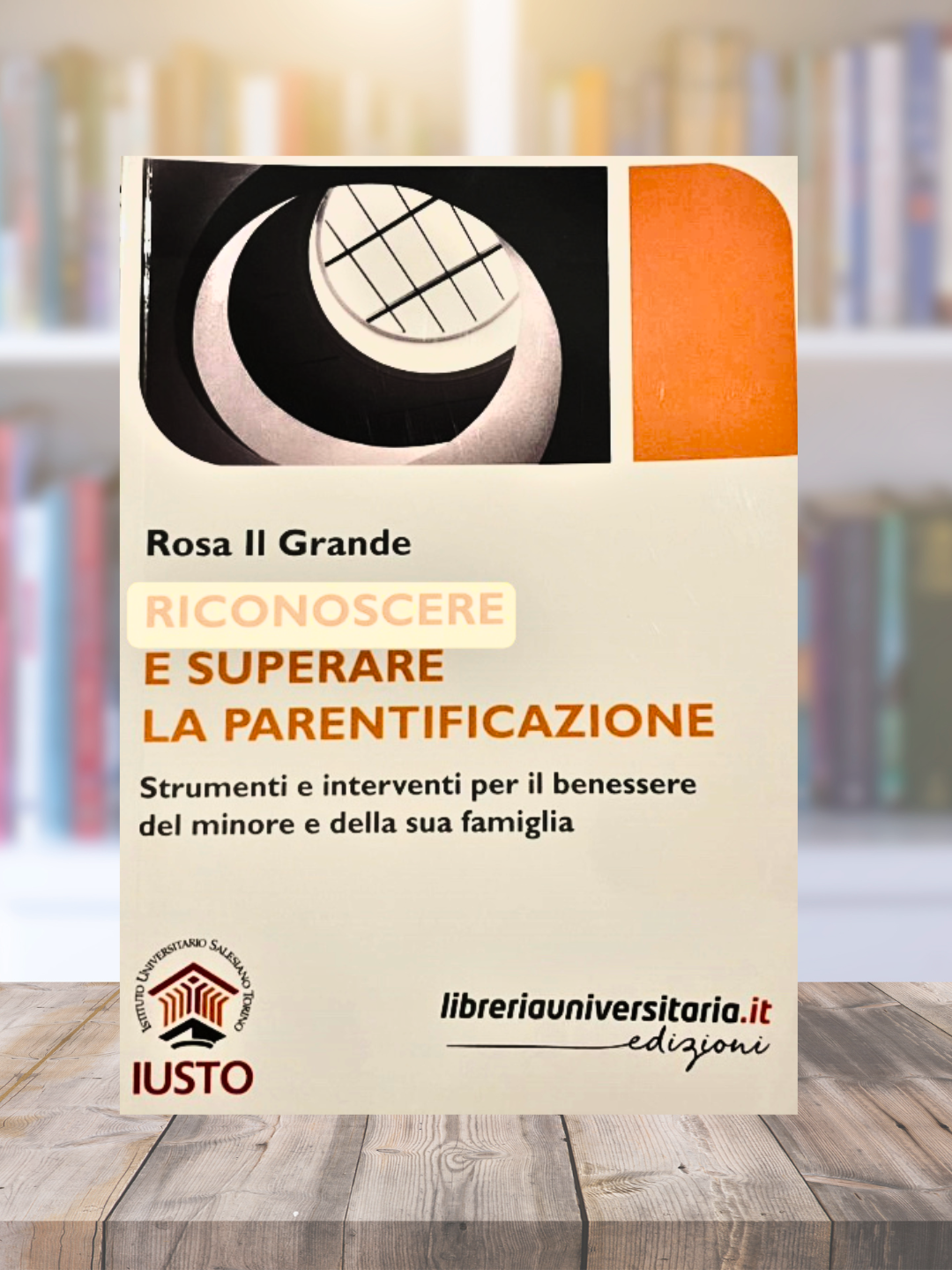 La Prof.ssa Rosa Il Grande, docente presso lo IUSTO – Istituto Universitario Salesiano di Torino, è psicologa clinica e di comunità, psicoterapeuta sistemico-relazionale, mediatrice e counsellor in sessuologia. Con una solida esperienza professionale e accademica, ha sviluppato una prospettiva che integra pratica clinica, ricerca e formazione. La sua attività si caratterizza per l’attenzione alle dinamiche relazionali e al benessere psico-sociale, temi che costituiscono il fulcro del suo impegno didattico e scientifico.
La Prof.ssa Rosa Il Grande, docente presso lo IUSTO – Istituto Universitario Salesiano di Torino, è psicologa clinica e di comunità, psicoterapeuta sistemico-relazionale, mediatrice e counsellor in sessuologia. Con una solida esperienza professionale e accademica, ha sviluppato una prospettiva che integra pratica clinica, ricerca e formazione. La sua attività si caratterizza per l’attenzione alle dinamiche relazionali e al benessere psico-sociale, temi che costituiscono il fulcro del suo impegno didattico e scientifico.
• Da quale percorso di ricerca o esperienza clinica è maturata l’idea di scrivere questo volume sulla parentificazione?
Più di dieci anni fa mi avvicinai a questa realtà nel tentativo di definire il tema di ricerca per il mio Dottorato di ricerca. All’estero vi erano molteplici autori che trattavano ed approfondivano questa realtà, mentre in Italia sembrava sconosciuta. Dopo aver approfondito a lungo il tema ed averne verificato la concretezza, nella pratica clinica dello studio e nel lavoro con le famiglie “fragili”, ho deciso di dedicarmi alla stesura di un testo che potesse riassumere, in modo esaustivo, la tematica, così da consentire a clinici, professionisti dell’educazione e genitori, di potersi approcciare a queste tematica consapevoli della sua complessità.
• Quale potrebbe essere una definizione chiara e rigorosa di parentificazione, sottolineandone gli elementi distintivi rispetto ad altre dinamiche familiari disfunzionali?
Per parentificazione intendiamo un processo relazionale disfunzionale in cui un figlio assume stabilmente ruoli, responsabilità o funzioni tipiche dell’adulto, in risposta ai bisogni emotivi o pratici dei genitori o di altri membri della famiglia, a scapito del proprio sviluppo psico-emotivo e divenendo a tratti “genitore dei propri genitori”, o meglio dell’adulto che lo ingaggia in questo ruolo. Si distingue per la sua funzione di compensazione dei bisogni genitoriali attraverso una precoce inversione di ruoli, spesso invisibile all'esterno e idealizzata all’interno della famiglia.
Si caratterizza per l’inversione dei ruoli generazionali: l’adolescente si comporta come un adulto nei confronti del genitore, se ne assume le cure, i compiti decisionali e il supporto emotivo che normalmente non spettano a lui. Tale ruolo assume i caratteri della persistenza e della sistematicità: non si tratta di un evento occasionale, ma di una dinamica cronica che si struttura nel tempo. La motivazione implicita o esplicita legata ai bisogni del genitore: Il minore agisce per rispondere a carenze o fragilità del genitore (come depressione, instabilità emotiva, dipendenza), non per una sua libera scelta o attitudine. La compromissione dello sviluppo del bambino. Il bambino sacrifica parti essenziali della propria crescita affettiva, sociale e identitaria, spesso sviluppando una precoce iper-responsabilità, difficoltà relazionali, senso di colpa o bassa autostima.
Esistono differenti tipi di parentificazione: strumentale, in cui il bambino si occupa di compiti pratici (cucinare, gestire fratelli, fare da intermediario tra genitori) ed emotiva, in cui il bambino fornisce sostegno psicologico al genitore, diventando confidente, mediatore o consolatore.
• Quali condizioni familiari e sociali predispongono maggiormente all’insorgenza di questo fenomeno?
Ottima domanda. La parentificazione è un fenomeno psicologico che spesso si attiva in risposta a un contesto familiare fragile o disfunzionale. Questo può portare a gravi conseguenze emotive e relazionali nell'età adulta.
Le condizioni familiari più comuni sono quelle che vedono genitori emotivamente immaturi o fragili; oppure genitori che faticano a gestire le proprie emozioni, ansie, o stress e si affidano ai figli per supporto emotivo, trattando il ragazzo come un confidente o un amico, come alcuni dei programmi televisivi in vaga negli ultimi anni.
Molto frequenti sono le situazioni in cui sono presenti malattie fisiche o mentali di un genitore. Sono situazioni in cui il figlio assume un ruolo di cura o di "equilibratore familiare".
Famiglie con problemi di alcolismo o droga, in cui il bambino può diventare il "genitore" di un adulto incapace di gestire la vita quotidiana. Famiglie con separazioni o divorzi conflittuali. In questi casi il minore può venire coinvolto nei conflitti tra i genitori, diventando un mediatore o prendendosi cura del genitore "più fragile". Famiglie monogenitoriali o in cui un genitore è assente fisicamente o emotivamente, il figlio può assumere responsabilità e ruoli adulti per "sostituire" il genitore mancante. Famiglie in situazione d’isolamento sociale o di eventi traumatici o catastrofici, come guerre, migrazioni forzate assumendo ruoli non adeguati alla sua età.
• È corretto affermare che la parentificazione non sia sempre e necessariamente patologica, ma possa talvolta avere anche funzioni adattive?
Sì, è corretto affermarlo, è una distinzione molto importante da fare. La parentificazione non è sempre patologica. In alcune situazioni, può avere funzioni adattive, aiutando il bambino (e la famiglia) a fronteggiare circostanze difficili. Quando non è eccessiva, prolungata o accompagnata da trascuratezza affettiva, può persino contribuire allo sviluppo di competenze come: senso di responsabilità, empatia, autonomia, capacità organizzative e maturità precoce. Possiamo definire questo tipo di parentificazione “funzionale” o “adattiva”, perché l’adolescente riesce a mantenere un equilibrio tra i suoi bisogni di crescita e le richieste familiari.
Può avere una valenza adattiva se è transitoria, riconosciuta, e bilanciata; ma può diventare patologica quando è prolungata, imposta, non compensata affettivamente, ed impedisce al bambino di svilupparsi in modo sano. In questi casi, la parentificazione può portare a disturbi dell’identità, relazioni disfunzionali, ansia, senso di colpa cronico e difficoltà a stabilire confini emotivi sani in età adulta.
• In che modo la parentificazione incide sui compiti di sviluppo tipici dell’adolescenza, in particolare sul processo di costruzione dell’identità?
Durante l’adolescenza, il compito evolutivo centrale è la costruzione dell’identità. In questa fase, i ragazzi iniziano a esplorare chi sono, a differenziarsi dalla famiglia d'origine e a sviluppare una propria visione del mondo, dei valori e dei progetti futuri. La parentificazione può interferire profondamente con questo processo. Può compromettere l’autonomia o il processo di separazione tipici dell’età, vincolando il ragazzo ai bisogni della famiglia, soprattutto del genitore fragile o assente, e implementando la difficoltà a separarsi psicologicamente da essa, così da rimanere invischiato in dinamiche familiari che ne limitano l’individuazione, basando la propria identità in funzione dei bisogni altrui e non dei propri desideri autentici.
L’adolescente può estremizzare il ruolo di “salvatore”, sviluppando un’identità fondata sul valore di essere utile, responsabile e indispensabile. Questo può portare a un iperinvestimento nel ruolo accudente, a discapito di altre dimensioni del Sé (creatività, spontaneità, errore). Può cadere in uno sviluppo emotivo inibito o distorto, perchè costretto a gestire le emozioni degli adulti, si torva a sopprime i propri bisogni e sentimenti. Compromettendo la capacità di riconoscere e regolare le proprie emozioni, fondamentali per una identità sana e integrata. Inoltre possiamo riscontrare una compromissione delle relazioni sociali. Il tempo e l’energia dedicati alla famiglia riducono lo spazio per le relazioni con i pari, fondamentali per l’identità adolescenziale, rischiando di scivolare nell’ isolamento, nel senso di diversità e nelle difficoltà relazionali. Infine, la parentificazione è spesso accompagnata dal senso di colpa: l’adolescente si sente in colpa se si dedica a sé stesso o se si allontana dalla famiglia, bloccandosi così, nella libera esplorazione di alternative di vita e ostacolandosi nelle scelte autonome.
• Quali bisogni evolutivi risultano maggiormente compromessi nei giovani coinvolti in queste dinamiche?
La parentificazione compromette lo sviluppo armonico del giovane, privandolo dell’esperienze essenziali per la crescita personale e relazionale. I bisogni più colpiti sono: protezione, autonomia, dipendenza sana, riconoscimento autentico, gioco/leggerezza e appartenenza. Il risultato è spesso un adulto iper-funzionante, ma interiormente fragile, con difficoltà a riconoscere e soddisfare i propri bisogni autentici. In una famiglia in cui il giovane deve "fare da genitore", manca spesso una figura affidabile che lo protegga e lo rassicuri, gestendo così situazioni emotivamente complesse. Sviluppa un'identità poco autonoma, spesso basata sull’adattamento agli altri piuttosto che sulla scoperta del proprio Sé; impara a non chiedere aiuto, a non fidarsi, e a vivere la dipendenza come vergognosa o pericolosa.
Sviluppa un senso di identità condizionato dall’approvazione o dal bisogno altrui, con rischio di bassa autostima o perfezionismo eccessivo; può maturare un profondo senso di isolamento, difficoltà a condividere, paura dell’intimità o creare relazioni sbilanciate anche in età adulta.
• In che misura il sostegno dei pari o di figure educative esterne alla famiglia può attenuarne l’impatto?
Il supporto sociale, inteso come rete esterna o percezione di aiuto, appare come fattore protettivo: ad esempio, in uno studio italiano su fratelli di persone con disabilità, il “social support” ha mitigato il distress correlato alla parentificazione. Inoltre l’attaccamento positivo ai pari (“peer attachment”) è risultato un eccellente distress per gli adolescenti con genitori affetti da malattia cronica. In sostegno delle figure educative esterne alla famiglia e dei pari consente di ridurre l’isolamento emotivo e permette di aumentare il riconoscimento così da sentirsi meno solo e diminuendo il carico emotivo. Inoltre nello scambio con i pari il minore aumenta la possibilità di accedere a nuovi modelli di coping alternativi sviluppando strategie di regolazione emotiva e di una migliore gestione del fardello eccessivo. In conclusione il sostegno dei pari e di figure educative esterne può giocare un ruolo importante nell’attenuare l’impatto della parentificazione sugli adolescenti, l’efficacia dipende dal contesto, dall’intensità della parentificazione, dalla qualità del sostegno e dalla presenza di interventi concomitanti nella famiglia.